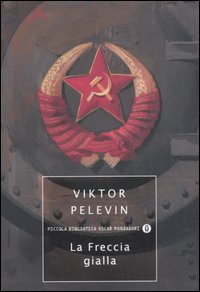
La freccia gialla
di Viktor Pelevin,
Mondadori editore 2006
La Freccia Gialla è un treno. Non se ne conosce l’origine, né si può stabilire quando sia partito: la sola certezza è che si dirige verso un ponte crollato. Impossibile sapere quando vi giungerà.
Le persone che vivono sul treno perlopiù ignorano il pensiero della destinazione, oppure lo tengono lontano ubriacandosi o concentrandosi sui loro piccoli traffici; molti di loro, completamente assuefatti al rumore delle rotaie, non sono nemmeno coscienti di essere dei passeggeri. Anche Andreij, protagonista del racconto, si troverebbe in questa condizione obliante, se il suo amico Khan non lo scuotesse con forza e non lo incalzasse con le sue domande (“Dove siamo? Che cosa stai sentendo adesso?”).
I soli a “scendere” dal convoglio sono i morti, che dopo le esequie vengono decorosamente gettati dal finestrino con tanto di fiori ed effetti personali; eppure, secondo il Khan c’è un modo per scendere vivi… certo, data l’assuefazione generale meglio non divulgare troppo la cosa: “non capiscono neanche che stanno viaggiando su un treno. […] Come fanno a capire ciò che sanno benissimo?”. Ma, si chiede Andreij, dal momento in cui si viaggia sapendo d’essere un passeggero (e si legge sapendo di essere un lettore, poiché costantemente rimandati all’assurdità della nostra stessa condizione!), come scendere dalla Freccia Gialla? E se anche ci si rende conto che “volere qualcos’altro è solo follia”, tuttavia la questione resta più che mai aperta: “Non so nemmeno chi sono io stesso. Allora chi si tirerà fuori da qui? E per finire dove?”.
Un ospite alla festa di Bon è il secondo scritto di questa “piccola” raccolta; qui l’ambientazione rivela in modo più esplicito (almeno per i non addetti ai lavori) l’interesse per le filosofie orientali del suo autore: se si considera infatti che Viktor Pelevin, scrittore russo seguitissimo dalle nuove generazioni e oggetto di intimidazioni da gruppi politici legati a Putin, è anche studioso appassionato di Zen, appare significativa la sua spinta a scrivere in prima persona della morte di Yukio Mishima. Il racconto è infatti una lunga soggettiva della testa dello scrittore giapponese, che rotola a terra dopo il plateale seppuku del ’70; l’attimo è dilatato, fisso su morte e bellezza, Giano bifronte che ha plasmato l’intera vita di Mishima. Ed è a questa ricerca che corrono gli ultimi brandelli del suo pensiero: ripercorrerne le tappe significa immergersi nella Domanda Fondamentale di un cuore certamente puro, per cui il suicidio significò dapprima l’uccisione di un Dio ingiusto, poi l’unica porta verso una verità che oltrepassasse la morte stessa, infine la “faccenda importantissima” di un burattino.
Solo ora che, con la testa di Mishima, cade pure ogni sua pretesa di trovare “il costruttore del [suo] meccanismo”, si svela il significato di un ricordo infantile, dell’inspiegabile sgomento provato davanti a un semplice cubo vuoto, un pomeriggio assolato di tanti anni prima. Le parole di Hagakure, il codice dei samurai che Mishima considerava il proprio breviario, gli si aprono ora come fiori notturni.
La ragione dichiarata per cui Lu Hong jian – protagonista di Nota sulla ricerca del vento e letterato vissuto nella Cina della dinastia Tang – scrive al grande Jiang Zi ya è il desiderio di rassicurarlo: no, non ha dimenticato l’esperienza che tempo addietro aveva vissuto sotto la guida del Maestro, dopo aver assunto la “polvere delle cinque pietre”.
In realtà, il terzo e ultimo racconto è una riflessione sulla scrittura, un piccolo capolavoro di autoreferenza: “è davvero possibile creare una narrazione incentrata sulla Via?”, si chiede l’autore della lettera prima dell’esperienza. E se è vero che le righe che egli manda al Maestro, intessute con cura e delicatezza, descrivono passo passo un potente risveglio, Lu Hong jian dichiara di aver fallito nell’intento di scriverne, negando di fatto la propria evidente affermazione (“come fare a dire una sola parola su ciò che non è mai diventato niente?”). In effetti “è difficile parlare del vento, se i segni esistono solo per le foglie che vi volano dentro”; e però, per quanto precisi che le sue righe possono essere “chiare solo a chi avesse vissuto la stessa esperienza”, la potenza di Lu Hong jian-Pelevin sta in questo: le sue bellissime metafore non cessano di rappresentare (e quindi tradire) la verità, ma insieme magicamente la mostrano ad ogni istante, attraverso “le parole [stesse], il cui mistero è ignoto”.




