Poche sono le frasi del nostro linguaggio che non contengano, in una delle sue possibili forme, il termine «essere». Se partiamo dall’osservazione che il linguaggio nomina ciò che in qualche modo ci ha colpito, ciò che ha per noi una qualche rilevanza, ci imbattiamo nella necessità di vedere meglio a cosa si riferisca questa quasi onnipresente parola.
La riflessione su cosa intendiamo con «essere» è antica quanto la filosofia, ma da ciò non deriva alcuna chiarezza a riguardo, anzi, tra i termini più ambigui che il sapere occidentale conosca vi è senz’altro quello di «essere».
Il pensiero del Novecento lo ha in molti casi considerato una nozione arcaica, appartenente alla preistoria della riflessione umana e non più in grado di dire qualcosa di significativo all’uomo contemporaneo. Soprattutto il positivismo logico lo ha destituito di qualsivoglia importanza, ritenendo che ad esso non possa corrispondere alcuna descrizione linguistica adeguata e che, pertanto, andrebbe eliminato da una filosofia rigorosa – che per questo orientamento di pensiero coincide con l’analisi logica del linguaggio.
I positivisti non sbagliano sostenendo che dell’essere non si possa dare una classica descrizione, ma questo significa che la questione non vada affrontata?
Non si dovrebbe, piuttosto, porre la domanda su cosa sia in grado di vedere e di descrivere il linguaggio e se l’intera realtà si esaurisca nelle sue descrizioni?
Lo sguardo scorge, infatti, ciò verso cui è orientato e predisposto, e non è detto che un certo orientamento non sia cieco a qualcosa di fondamentale.
Fondamentale è, per Heidegger, proprio la questione dell’essere, della quale per tutta la vita egli cercò di ristabilire la centralità, riflettendovi incessantemente e cercandone tracce e riferimenti nell’opera di altri pensatori.
 Il primo a cui deve l’incontro con la questione, perlomeno dal punto di vista dell’espressione teorica, fu Franz Brentano che nel 1862 aveva pubblicato Il molteplice significato dell’essente in Aristotele. In seguito a questa lettura «pur se in modo sufficientemente impreciso, mi muoveva il pensiero: se l’essente è detto in più sensi, quale ne è allora il significato guida fondamentale? Che significa ‘essere’?» [1]
Il primo a cui deve l’incontro con la questione, perlomeno dal punto di vista dell’espressione teorica, fu Franz Brentano che nel 1862 aveva pubblicato Il molteplice significato dell’essente in Aristotele. In seguito a questa lettura «pur se in modo sufficientemente impreciso, mi muoveva il pensiero: se l’essente è detto in più sensi, quale ne è allora il significato guida fondamentale? Che significa ‘essere’?» [1]
Questa domanda, chiedendo quale sia l’essenza, il significato unificante di diversi modi di concepire e dire l’essente, rientra appieno nello spirito della riduzione eidetica inaugurato dalla fenomenologia. È un tentativo analogo a quello di chiedersi cosa mi permette di considerare «uomini» individui differenti. L’ambito indagato da Heidegger è però più radicale dal momento che non coincide con le visibili qualità, ma riguarda l’invisibile essere, ciò che trascuriamo massimamente perché non sappiamo più come trovare e forse neanche come cercare.
Per Heidegger si tratta di un tema complesso da intendere, che richiede di affinare gli strumenti d’indagine o addirittura, per l’inadeguatezza di quelli consueti, di trovarne di nuovi.
L’«oggetto» in questione, infatti, si presenta fin da subito in modo piuttosto singolare e sfuggente allo sguardo ordinario, permettendo un avvicinamento solo tramite la negazione di ciò che esso non è:
«Ma l’essere è una cosa? – si chiede Heidegger – L’essere è nel tempo così come un qualsiasi essente che di volta in volta è? E, soprattutto, l’essere ‘è’? Se esso fosse allora noi dovremmo immancabilmente riconoscerlo come qualcosa di essente e conseguentemente incontrarlo come tale tra il resto dell’essente. (…) Ma dove (…) noi troviamo lo ‘è’? In nessun luogo tra le cose noi troviamo l’essere.» [2]
E’ proprio perché si tratta dell’essere, quindi, che non possiamo permanere nell’ambito della descrizione. Ma il fatto che l’essere sia introvabile fra le cose visibili non significa che si tratti di una questione inconsistente, non reale.
Per poterne interrogare il senso è però necessario scorgere in che modo esso sia dato. Come arrivare ad un’esperienza dell’essere, o come evidenziarne la presenza nell’esperienza che già si sta dando?
Heidegger riconosce alla fenomenologia il merito di aver aperto la possibilità di una presentificazione dell’essere.
Husserl indica infatti un luogo nell’esperienza percettiva in cui emergerebbe «essere». Grazie a questo Heidegger trova «un terreno su cui poggiare: essere non è più un semplice concetto, non è un’astrazione pura ottenuta tramite la deduzione.» [3]
L’analisi fenomenologica mostra quindi che, in qualche modo, l’esperienza dell’essere si dà. Ciò che è difficile è individuarla fedelmente, interrogarsi in modo da darle lo spazio che esige e che, attualmente non ha affatto. Nella visione attuale, infatti, secondo Heidegger:
«La determinazione dell’essere come esser-presente è ciò che domina anche la visione tecnica, che dà ad intendere l’essente come ciò ‘che è a disposizione del calcolo manipolante’. Ogni cosa di cui noi diciamo ‘è’, viene immediatamente rappresentata come qualcosa di essente. Ma l’essere non è niente di essente.» [4]
Quello di Heidegger vuole essere un
«tentativo che pensa l’essere senza riguardo a una fondazione dell’essere a partire dall’essente. Il tentativo di pensare l’essere senza l’essente diviene necessario, poiché altrimenti non sussiste più alcuna possibilità, a quel che mi sembra, di portare espressamente allo sguardo l’essere di ciò che oggi è intorno al globo terrestre, ancor meno di determinare sufficientemente il rapporto dell’uomo a ciò che finora si chiamava ‘essere’. » [5]
In questa ricerca, dunque, ne va dell’uomo, non di quel che ad un pensiero ingenuo potrebbe apparire come un’astrazione, come il più generale dei concetti e il più distante dall’esperienza vissuta.
L’essere non è qualcosa di essente, dunque. Ma allora è qualcosa di non essente? Il pensiero ingenuo si muove, ponendoli in alternativa, tra i due estremi della presenza e dell’assenza e non riesce a trattenere l’essere tra le sue maglie.
Per andare oltre questi limiti è necessario uno strumento più originario del pensiero descrittivo e teorizzante, che vada oltre il modello oggettivante del vedere. Heidegger lo trova nella fenomenologia, che non mette a disposizione solo un contenuto di pensiero, ma una «possibilità», che però, tuttora, resta inaccessibile e non valorizzata.
Dice Heidegger:
«L’epoca della filosofia fenomenologica sembra essere finita. La si ritiene già come qualcosa di passato, che può essere caratterizzato solo storiograficamente accanto ad altri indirizzi filosofici. Ma la fenomenologia in ciò che le è proprio non è affatto un indirizzo filosofico. Essa è la possibilità del pensiero – possibilità che si modifica a tempo debito e solo perciò permane come tale – di corrispondere all’appello di ciò che si dà da pensare. Se la fenomenologia è così esperita e salvaguardata, allora essa può sparire come voce filosofica a favore della cosa del pensiero, la cui manifestatività resta un arcano.» [6]
Partiamo dal fatto che, in qualche modo, pensiamo, che siamo costantemente attraversati da questa attività. Cosa ci chiama a pensare? Heidegger parla di un vero e proprio appello a cui corrispondere, di un richiamo che, per poter essere corrisposto, va prima di tutto inteso adeguatamente. La fenomenologia costituirebbe la possibilità di far luce sullo scaturire e sullo svilupparsi di questo nostro pensare.
«Alle cose stesse!» recita il motto husserliano nel quale si è incarnata la volontà conoscitiva di molti, ma – si chiede Heidegger – qual è la «cosa» da pensare? Il vero pensiero a cui tutta la sua riflessione mira è il pensiero dell’essere dove «questo genitivo dice allora che l’essere in quanto tale (l’Essere [Seyn] si mostra nel contempo come quel «da pensare» che ha bisogno di un pensiero che gli corrisponda.» [7]
In appendice ad Essere e tempo Heidegger ribadisce:
«L’essenziale per la fenomenologia non sta nell’essere reale come corrente filosofica. Più in alto della realtà si trova la possibilità. La comprensione della fenomenologia consiste esclusivamente nell’afferramento di essa come possibilità.» [8]
E come possibilità continua ad esercitare il suo richiamo su chi sente il bisogno di fare chiarezza nella propria personale esperienza, su chi, pur ritrovandosi a pensare, non si sente di dare per ovvia questa attività e si interroga sul reale bisogno che la genera.
Cos’è il pensiero? Da dove nasce?
In nome di quale sua caratteristica esso è, alla pari delle cose da esso pensate, «da pensare?»
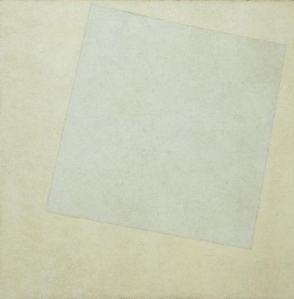
Voler capire questo bisogno genera una tensione verso l’origine dell’esperienza, una tensione che prende forma di domanda e, poiché anche la domanda non è per nulla ovvia, ci ritroviamo a domandarci: cos’è una domanda?
Quale risposta potrà mai soddisfarci? Una risposta non è una domanda, non può dirci cosa sia una domanda…ecco che il pensiero che si impegna a fondo in un tentativo di autocomprensione deve riconoscere la ricchezza dello stato interrogante e soffermarsi in esso.
Ma a partire da quale esperienza scaturiscono le domande?
E a partire da quale esperienza il pensiero deve cimentarsi con la questione dell’essere?
L’ESSERE SECONDO HUSSERL E L’ESSERE SECONDO HEIDEGGER
L’analisi di Husserl
Secondo Heidegger, Husserl sarebbe giunto molto prossimo ad una formulazione della questione dell’essere nella VI delle Ricerca Logiche.
Le Ricerche Logiche, apparse in due volumi tra il 1900 e il 1901, compiono un passo rivoluzionario perché mostrano il legame indissolubile tra il mondo dei concetti della logica formale e della filosofia e il vissuto soggettivo.
Il soggetto vivente viene riconosciuto come il fondamento e la condizione di possibilità dei problemi logici e linguistici.
È da un soggetto infatti che scaturisce il bisogno e la donazione di senso. Senza di questo non avrebbe senso neanche parlare di significati e di verità, senza legami col bisogno di capire proprio di qualcuno un significato non sarebbe neanche tale.
In questo modo Husserl compie una mossa doppiamente rivoluzionaria. Prima di tutto valorizza dal punto di vista conoscitivo quell’esperienza in prima persona che viene quasi sempre assimilata a prospettive relative e contrapposta all’obiettività dei concetti universali. E poi, orientando l’attenzione sull’attenzione stessa, porta alla luce quel polo che, pur costitutivo di ogni esperienza, resta quasi sempre nascosto ed invisibile al suo stesso sguardo.
 Compie in questo modo il primo passo di un processo che potremmo chiamare di svelamento dell’inapparente, che riguarda il soggetto e poi, vedremo come, l’essere.
Compie in questo modo il primo passo di un processo che potremmo chiamare di svelamento dell’inapparente, che riguarda il soggetto e poi, vedremo come, l’essere.
Riconoscere dignità conoscitiva all’ambito soggettivo non significa che ogni opinione possa acquisire validità, ma che nell’esperienza si danno elementi inconfutabili e certi come, ad esempio, che si produce un’opinione e che qualcuno la coglie come tale.
La caratteristica dell’obiettivismo, invece,
è quella di muoversi sul terreno del mondo già dato come ovvio nell’esperienza e di perseguirne la ‘verità obiettiva’, ciò che in esso è incondizionatamente valido per ogni essere razionale, ciò che esso in se stesso è.» (C., p. 97)
Ma, acutamente, Husserl osserva che un’obiettività non è un’entità autosussistente, deve essere rappresentata da qualcuno e in questo senso diventa soggettiva. Nella introduzione del 1913 al secondo volume delle Ricerche Logiche Husserl si domanda:
«che cosa significa che l’oggetto sia ‘dato in sé’ e nella conoscenza; come può l’idealità del generale, in quanto concetto o legge, presentarsi nel flusso dei vissuti psichici reali e diventare possesso conoscitivo del soggetto pensante?» [9]
I significati nell’esperienza umana
Nella prima parte delle Ricerche – intitolata Prolegomeni a una logica pura – Husserl chiarisce come occuparsi dell’esperienza vivente in relazione alla logica e alla conoscenza sia ben diverso dal fare della psicologia. La logica deve anzi svincolarsi da quest’ultima e acquisire una struttura indipendente. Ciò che è rilevante nell’esperienza vivente non sono infatti i processi neuro-bio-fisiologici, ma i significati che in essa emergono. La fenomenologia si dimostra così molto critica verso ogni riduzione dell’attività conoscitiva umana alle sue componenti cosiddette materiali:
«Infatti prescindendo da qualsiasi contenuto e da qualsiasi principio formale umano, la logica mostra come esistano leggi che esulano e che in fondo sono indipendenti dalla costituzione umana in generale. (…) il fine husserliano è quello di conservare la validità di logica e psicologia, ma all’interno dei loro ambiti specifici, smontando così sia le loro critiche reciproche, sia la loro pretesa di universalità. (…) I logici psicologisti non colgono il fatto che la comprensione ideale e la spiegazione causale restano eterogenee, in altre parole non riconoscono che tra legge ideale e legge reale, tra norma e causa, tra giustificazione logica e fondamento reale vi sono differenze essenziali e invalicabili.»[10]
La seconda parte– Ricerche sulla fenomenologia e sulla teoria della conoscenza – sviluppa una teoria fenomenologica del significato, dell’espressione, del linguaggio e delle sue forme di conoscenza.
Husserl osserva che tutto il pensiero, e in particolare tutto il pensiero e la conoscenza teoretica, si effettua in certi «atti» che intervengono all’interno del discorso espressivo.
Per lui l’elemento significativo di ogni nostro atto risiede nell’esperienza vivente di tale atto, e non nell’oggetto, nel contenuto dell’atto.
Questa precisazione è importantissima perché sposta l’attenzione dall’oggetto percepito al fatto di percepire, a quel contatto tutto da indagare in cui l’oggetto si manifesta al soggetto o il soggetto stesso si manifesta a se stesso:
«noi viviamo le manifestazioni come appartenenti al nesso della coscienza, mentre le cose ci si manifestano come appartenenti al mondo fenomenale. Le manifestazioni stesse non si manifestano; vengono vissute.» [11]
Vissuto non è il mondo, ma l’intendere-il-mondo, il mondo è l’oggetto inteso.» (II, 175).
Nella prima Ricerca, che affronta il tema del rapporto fra espressione e significato, Husserl scrive che:
«poiché il significato non è una datità che risiede negli atti o negli oggetti di coscienza, ma è un atto intenzionale che si trova nella coscienza, esso è quel riferimento dell’espressione all’oggetto che assume un valore intenzionale nel riempimento di senso.» [12]
Segue parte 2
[1] Tempo ed essere, Napoli 1980, p. 183.
[2] Tempo ed essere, p 99.
[3] Heidegger, Seminari, pp. 152-153.
[4] Tempo ed essere, p.104.
[5] Tempo ed essere, p. 98.
[6] Tempo ed essere, p. 190.
[7] Lettera a W.J. Richardson del 1962, in Fenomenologia, a cura di R. Cristin, Unicopli, Milano 1990, p. 242.
[8] Tempo ed essere, p. 191.
[9] E. Husserl, Ricerche Logiche, Mondadori, Milano 1988, vol. II, pp. 273-274.
[10] Cristin, Invito al pensiero di Husserl, pp. 54-55.
[11] Ricerche Logiche, V, II, p. 142.
[12] Cristin, p. 59.




